Un silenzio angosciante ha accompagnato l’assedio, lo sgombero e l’uccisione di due persone nell’operazione di deportazione interna che lo Stato ha attuato nella provincia di Foggia ai primi di marzo.
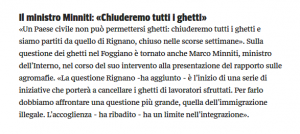 Il silenzio è il nostro, è quello delle mancate azioni. Questa spietata operazione militare vuole ripetersi nei restanti ghetti della provincia, così come per la tendopoli di San Ferdinando in Calabria: a dimostrarcelo non sono solo le parole del neo-ministro sanguinario Minniti, ma quanto sta avvenendo in diversi accampamenti informali lungo la penisola, passando da Foggia a Caltanissetta.
Il silenzio è il nostro, è quello delle mancate azioni. Questa spietata operazione militare vuole ripetersi nei restanti ghetti della provincia, così come per la tendopoli di San Ferdinando in Calabria: a dimostrarcelo non sono solo le parole del neo-ministro sanguinario Minniti, ma quanto sta avvenendo in diversi accampamenti informali lungo la penisola, passando da Foggia a Caltanissetta.
Le condizioni “indecorose” di vita nei campi improvvisati, dove sopravvivono le persone deliberatamente emarginate dalle leggi sull’immigrazione, sarebbero il pretesto per attaccare questi luoghi e trarre maggior profitto, oltre che dallo sfruttamento quotidiano, anche dalla gestione di migliaia di vite.
Guardando alle conseguenze dello sgombero del Gran Ghetto di Rignano, l’installazione di due “campi di lavoro” di Stato, dove gli ingressi vengono sorvegliati dalla polizia e regolati da un orario legato alla produzione e dove la distribuzione dei pasti viene appaltata a una ditta esterna, ha comportato l’inclusione temporanea per alcuni, l’esclusione per altri/e che sono stati/e costretti a vivere per strada, in condizioni peggiori rispetto a quelle del campo distrutto dalle autorità.
In questi giorni abbiamo letto molte considerazioni riguardo questa tragedia: dal tastierismo militante alla CGIL passando per le associazioni umanitarie come Emergency e MEDU; tutti sembrano concordare sulla necessità di radere al suolo i ghetti e le tendopoli poiché bacino per i caporali che approfittano di persone costrette a vivere in condizioni estreme.
Ci chiediamo quindi se lo sgombero del Gran Ghetto abbia ripristinato la conclamata legalità, se dunque ora nei due nuovi campi l’intermediazione attraverso i caporali sia scomparsa perché le aziende agricole applicano i contratti e sono attivi servizi di trasporto per i luoghi di lavoro; se la vita delle persone sia migliorata dopo la distruzione del ghetto, portato avanti, a causa della resistenza dei suoi abitanti, per ben 4 giorni ed eseguito a ogni costo, compreso quello di due persone bruciate vive.
La risposta alla domanda retorica è ovviamente negativa: per chi abita nei due campi poco è cambiato ma varie centinaia di migliaia di euro, che non potevano venir stanziati per case, trasporti e assistenza sanitaria, ora affluiscono nelle tasche di chi costruisce e gestisce i nuovi ghetti di Stato.
Basta poi guardare a chi firma i protocolli per collaborare nella gestione dei nuovi campi per capire chi guadagnerà dagli sgomberi.
 Lo stesso tipo di operazione avvenuta a Rignano è ora programmata nella grande tendopoli di San Ferdinando, dove vivono 2000 persone. Per due giorni la polizia ha circondato il campo, non permettendo a nessuno di uscire, eseguendo perquisizioni a tappeto tenda per tenda, controllando i documenti, portando persone in questura e arrestando una donna. Intorno al ghetto la presenza di forze dell’ordine è quotidiana, le identificazioni di migranti e solidali sono diventate la norma. Dopo il taglio della corrente elettrica a gennaio, negli ultimi giorni sono state chiuse le piccole botteghe dove era possibile comprare dei beni di prima necessità, dal cibo ai prodotti per l’igiene. Le autorità mostrano il pugno di ferro rendendo le condizioni di vita ancora più difficili, cercando così di costringere le persone ad allontanarsi “spontaneamente”. Nel frattempo nelle vicinanze si costruisce il nuovo campo: un’area delimitata da una recinzione dove portare solo 300/500 persone munite di documenti.
Lo stesso tipo di operazione avvenuta a Rignano è ora programmata nella grande tendopoli di San Ferdinando, dove vivono 2000 persone. Per due giorni la polizia ha circondato il campo, non permettendo a nessuno di uscire, eseguendo perquisizioni a tappeto tenda per tenda, controllando i documenti, portando persone in questura e arrestando una donna. Intorno al ghetto la presenza di forze dell’ordine è quotidiana, le identificazioni di migranti e solidali sono diventate la norma. Dopo il taglio della corrente elettrica a gennaio, negli ultimi giorni sono state chiuse le piccole botteghe dove era possibile comprare dei beni di prima necessità, dal cibo ai prodotti per l’igiene. Le autorità mostrano il pugno di ferro rendendo le condizioni di vita ancora più difficili, cercando così di costringere le persone ad allontanarsi “spontaneamente”. Nel frattempo nelle vicinanze si costruisce il nuovo campo: un’area delimitata da una recinzione dove portare solo 300/500 persone munite di documenti.
Chi vive nelle grandi città ha già conosciuto le campagne repressive che precedono gli sgomberi di interi edifici da svuotare e demolire per riportare “decoro e legalità” in un quartiere, quando palazzine o intere popolazioni di quartieri periferici vengono per mesi descritte da politici e media come “covi per criminali o clandestini” e “gestiti dal racket e dalla malavita”. Palazzine o intere colate di cemento chiamate periferie, che non sono certo la “vita desiderata” da tanti ma che hanno conosciuto la resistenza delle persone che vi abitano perché lo sgombero significava l’espulsione dalla città, la recisione di tutte le relazioni e le abitudini costruite nel tempo o la vita appesa all’ospitalità temporanea in un residence.
Quelle in provincia di Foggia e altrove sono lunghe operazioni militari che dobbiamo osteggiare; non iniziano e non finiscono lì e le due persone uccise, Mamadou e Nouhou, gridano vendetta.
 Una vendetta che forse sarebbe iniziata prima se fossero stati due abitanti italiani di un qualsiasi ghetto metropolitano ad aver perso la vita.
Una vendetta che forse sarebbe iniziata prima se fossero stati due abitanti italiani di un qualsiasi ghetto metropolitano ad aver perso la vita.
Le grida invece, quelle delle stesse persone in lotta contro lo sfruttamento e la segregazione, per conquistare documenti, casa e contratti per tutti e tutte, sono quelle che dobbiamo sostenere perché nessuno sgombero ha mai garantito a nessuno/a la vita desiderata.
